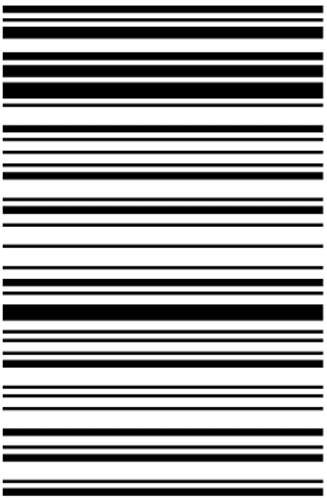L’uomo in nero ne aveva tante da raccontare. Anche a loschi individui come quelli che si trovava di fronte. D’altra parte, era andato lì per quello. Cantargliele. Ma mica perché ce l’avesse con loro, oh no – lui si sentiva uno di loro. E quella gente, da par suo, lo rispettava: lui era un idolo, un eroe, uno che ce l’aveva fatta, uno che era uscito e ne era uscito. Apparentemente, un vincitore. Uno che era emerso dalla fossa di mediocrità in cui loro erano affondati, chi più colpevolmente, chi magari un po’ meno. Suvvia: era famoso, aveva una moglie e – dettaglio non esattamente privo di rilevanza – era un uomo libero. Nonostante tutto. Nonostante tutto quello che avesse da raccontare. “I keep a close watch on this heart of mine”, verrebbe da dire, ma no. Lui quel giorno “I walk the line” non gliela cantò. Non era il giorno per le hit, non era il giorno per i melodrammi personali, non c’era nessuno da celebrare. Lui non era andato lì a offrire sé stesso in uno show. Meno ancora era lì per soldi. Lui era andato lì per stare con loro. Per redimersi, forse, per poter dare loro qualcosa indietro. Per scusarsi dell’essere stato solo un po’ più intonato, e fortunato, di loro. E cosa poteva fare per comunicare con loro, se non utilizzare il mezzo che meglio conosceva? Il metodo comunicativo a lui più congeniale, nonché paradossalmente il veicolo ideale in quel contesto? Ma, ammettiamolo, anche quello che pochi avrebbero creduto realizzabile. Del resto, il suo stesso datore di lavoro non era particolarmente entusiasta della sua idea. Eppure lui non fece marcia indietro, convinto del suo progetto. La buona sorte si occupò del resto, con Clive Davis nel frattempo impegnato su altri orizzonti, tra cui la gestione delle new entry nella banda Columbia – solo pochi mesi prima Janis Joplin aveva detto sì al sodalizio con l’etichetta di Washington. Via libera.
When I was just a baby
My mama told me
Son, always be a good boy
Don’t ever play with guns
But I shot a man in Reno
Just to watch him die
When I hear that whistle blowin’
I hang my head and cry”
Blues in punta di piedi, country del sapore agrodolce, ritmo educatamente incalzante. Senza ferire ma senza omettere, perché con le giuste parole si può dire tutto, ma proprio tutto. “Qualche volta anche io sono stato in posti come questo”, giusto per mettere le cose in chiaro. O per ammissione di colpa. “La mamma me l’aveva detto, di non giocare con la pistola, ma ora piango a testa bassa”; abbiamo pareggiato i conti, siamo sullo stesso livello. Non è lui che ha i riflettori puntati addosso – la platea è parte integrante dello show, i protagonisti sono i messaggi, che scorrono quasi in risonanza gli uni con gli altri. Racconti, esperienze, tutto raggiunge il cuore. Lui ci crede, lui la vive. Il suo modo di comunicare è di conseguenza coerente, fluente, sentito, sincero. Un sentimento declinato in musica. Ogni solco del vinile registrato quella mattina trasmette un insegnamento, filtra un secondo di vita. Le interpretazioni e la significatività di “25 minutes to go”, di “Send a picture of mother”, della conclusiva “Greystone chapel”, scritta da un detenuto stesso, non si limitano ad essere “semplicemente” capisaldi della musica contemporanea, ma si assumono la responsabilità di fornire evidenza oggettiva di quale sia il modo migliore per comunicare: vivere e credere in ciò che si vuole trasmettere. Esattamente quello che farebbe un Safety Leader.
Era il 1968. Loro erano i detenuti del carcere di Folsom, e lui era Johnny Cash, la più grande rockstar della comunicazione di sempre.

SCORRI LA PAGINA E LASCIA UN COMMENTO.