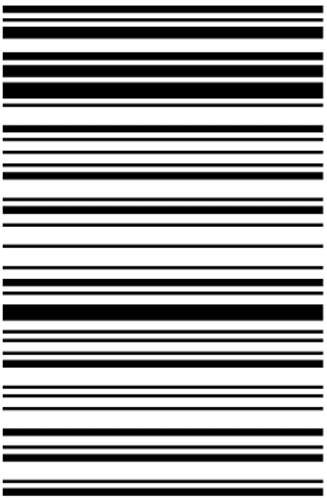Il fast fashion (moda veloce in italiano) è il termine usato per rappresentare quel modello per cui la moda passa rapidamente dalle passerelle ai negozi, per permettere al consumatore di acquistare capi di ultima tendenza a basso prezzo.
Il fast fashion, nella sua definizione, farebbe leva sull’ottimizzazione per produrre in modo rapido ed economico, enfatizzando la produzione piuttosto che il prodotto.
La verità non è così bella come è presentata nelle definizioni, però.
Tutti noi abbiamo nei nostri armadi più vestiti di quanto necessitiamo, se ci guardiamo bene dentro, i capi di abbigliamento non sono mai costati così poco e siamo chiaramente circondati da un ambiente che ci spinge a cambiarci, anche più volte al giorno, ad utilizzare i vestiti una volta e mai più, a seguire le tendenze di una moda che cambia sempre più rapidamente, ad acquistare in ogni caso, se non va bene o non ci piace tanto poi c’è il reso.
E se vi dicessi che questi vestiti dovrebbero costare molto di più di quello che li paghiamo?
Purtroppo il prezzo che non paghiamo noi, sono altri a pagarlo.
Molti dei vestiti che vengono resi o che restano invenduti a causa della sovrapproduzione, vengono spediti in Paesi come Cile o Ghana insieme a donazioni, dove danno origine ad un nuovo mercato che sfrutta i piccoli rivenditori a vantaggio dei grossisti. I capi che noi restituiamo come resi, spesso gratuitamente, a volte sono meno costosi dell’energia, del personale e del tempo che ci vuole per ricondizionarli (ovvero lavarli, disinfettarli, stirarli), e finiscono quindi nello stesso circolo destinato ai capi non più venduti nei Paesi occidentali, e spediti in Africa o Sudamerica.
Solo ad Accra, in Ghana, al Kantamanto Market ogni settimana arrivano 15 milioni di vestiti.
I vestiti sono racchiusi in enormi sacchi e venduti a scatola chiusa. Il piccolo rivenditore, che non ha altra scelta, compra, sperando di rivendere. Alcuni dei capi però non sono vendibili, perché molto rovinati oppure perché sono scarpe o indumenti invernali, inutili nei climi tropicali di quei Paesi.
Tutto ciò che non è più rivendibile (più della metà degli indumenti) soffoca le città e gli ambienti locali con enormi discariche, dove i bambini giocano, gli animali pascolano, la gente vive.
Per non parlare delle condizioni di questi piccoli rivenditori, spesso giovani donne, che trasportano da sole ogni giorno i sacchi di vestiti, che pesano ognuno dai 45 ai 60 kg, per uno stipendio da fame.
Altrettanto devastante è la produzione di questi indumenti. Ciò che si nasconde dietro le parole ottimizzazione o economie di scala spesso si traduce in trasferire in altri Paesi ciò che da noi costa molto di più o non si può fare.
Ma, ancora una volta, la differenza di prezzo è qualcun altro a pagarla.
In Bangladesh la produzione di massa a basso costo genera condizioni di lavoro inaccettabili, con lavoratori in completa assenza di qualsiasi misura di protezione a fronte di una presenza di rischi altissimi, anche chimici, costretti a lavorare tutti i giorni fino a oltre 12 ore per uno stipendio medio di 78 dollari al mese (ce ne vogliono 250 per vivere dignitosamente in quel Paese).
Indicibili sono anche i danni causati all’ambiente, come in Indonesia, dove migliaia di ettari di foresta verde sono tolti alle popolazioni locali e rimpiazzate da terreni a crescita esclusiva di eucalipto, distruggendo completamente la biodiversità autoctona, oppure sempre in Bangladesh, dove a causa dei prezzi bassi di acquisto dei grandi brand occidentali i rifiuti non sono smaltiti correttamente, inquinando le terre e le falde acquifere circostanti.
Non basta sicuramente un articolo per parlare di un tema così complesso, vi invito per questo a guardarvi la docu-serie di Matteo Ward: Junk – armadi pieni sul canale Youtube di Sky Italia, su Sky on demand o su Now, che in maniera inclusiva e senza farci sentire in colpa ci cattura per farci avvicinare al tema in maniera consapevole, e ci dà anche degli spunti per andare nella giusta direzione.
Un passo alla volta, ognuno di noi può fare qualcosa.
Visita l’intera rubrica Hse on stage!
SCORRI LA PAGINA E LASCIA UN COMMENTO.